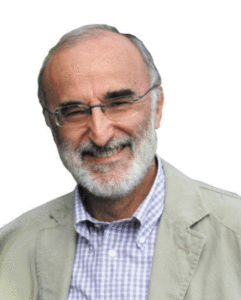
Si pubblica, per gentile concessione dell’editore, la prefazione al libro di Filippo Davoli “Dentro il meraviglioso istante”, uscito in questi giorni per i tipi di “Carta Canta”
Non so bene perché, ma mi torna alla mente, per questo libro di Filippo Davoli, un testo dolcemente evocativo di Valerio Magrelli (“Miracolo della dolcezza”), che apre la sezione Paesaggi laziali della raccolta Il sangue amaro. È dedicato alla memoria di un antico compagno “nella galera dell’adolescenza” ed evoca una vita a rovescio che genera – nella memoria – la nostalgia di un incontro. Riuscendo così affine ai due versi che giudico – tra tutti – misteriosamente esemplari: “Dov’è la libertà, se la malinconia/ raccoglie le sue nuvole senza nessun perché?”.
Non ho perché da vantare qui, se non che questo testo – non sto proponendo dipendenze – contiene parole e sentimenti che sono così prossimi all’opera in generale di Davoli, e in particolare all’opera ultima, Dentro il meraviglioso istante. Libro di dolcezza e grazia diffuse – effuse mai –; libro di vigile nostalgia, ma nostalgia non tanto o non solo del ritorno, riconosciuto tema-chiave, e piuttosto di alterità, di assoluto, di quotidiana collocazione e di cosmica congiunzione (“il cosmo lieve delle mie giornate”), di fusione (“Siamo un costrutto di attimi”) che non esito a definire spirituale, ricordando come Franco Loi abbia fin da principio obliquamente parlato di “atteggiamento mistico”; libro, ancora, di malinconie variamente declinate (“e un filo di malinconia quasi mi tiene”), che la presenza frequente di nuvole e “nuvolaia” trasforma e dissipa (i tanti sfarsi e disfarsi), alleggerisce e incanta “senza nessun perché” (ma anche, in un testo specifico, il notevole paragone: “Sono amiche, le nuvole. Come i morti/ che ammiccano e dispaiono/ e tu le guardi volare, librarsi/ sospinte da un loro vento invidiabile”); libro, infine, di comunione e di comunità, capace di convocare nei suoi incontri i giorni e i luoghi, il trauma del terremoto, il padre e la madre (figure-timone), la non carducciana nonna, gli amici e i parenti, i vivi e i morti, le persone frequentate e le persone più casualmente sfiorate.
Comunità di luogo, ma comunità altresì “degli animi”, secondo una vaga assonanza sabiana (un meno egoico Saba borghigiano), in un componimento che ha tutta la nitidezza un poco gnomica dell’elegia pensosa, dell’incisione povera, elementare, espressa in forma quasi spoglia, quasi disarmata, e aggiungerei ingenua, ma nel senso etimologico di “libera”: “Le strade. Dove pullula la vita migliore,/ la più anonima e indaffarata./ Le strade dove gli uomini si incrociano/ e sognano la sera che cala/ e li conduce agli svaghi/ brevi come durata, intensi nel desiderio./ Poveri uomini, amate spoglie sorelle/ che tutti siamo parte del tutto/ e gli uni degli altri/ ma come è naturale non saperlo”. Ma si veda poi l’elogio maceratese che chiude senza perplessità e distinguo: “Bella anch’essa da viversi/ la gente del mio rione”. O anche l’incontro con la donna dell’ombrello aperto “sotto i portici”: “Era invece un abbrivo di quelli miei soliti/ quando indugio per le strade del mio quartiere”.

Non tutto è ovviamente riconducibile alla pretestuosa citazione da Magrelli, ma riconducibile di certo è a una vocazione mai smentita, che fa dire allo stesso Davoli (se ne veda la “piccola nota dell’autore”): “Che chi scriva sempre lo stesso libro è attendibile, così come si vive – pur nelle svolte che la ricominciano – la medesima vita. Cambiata di tono, arricchita dall’esperienza, con-vertita, ma il fondamento rimane quello che l’ha originata”.
Sottile distinguo, tuttavia, perché – pur nella continuità del fare – non si nega qui né la variazione dei tempi né la variazione dei toni. Come a dire che la vita ha i suoi punti di stazione e di svolta, di continuità e di diversione (o, stando allo stesso Davoli, di “con-versione”, nemmeno escludendone la religiosa piegatura: “Andiamo, il giorno è alto”), ma che anche l’opera ha i suoi passaggi, le sue transizioni di lingua e di stile: il tutto in tratteggio di paesi, in incanti di profili, in lungimiranza di prospettive, in allusività di confini.
E se devo dire subito, subito dirò che quest’ultimo libro di Davoli mostra più di tutti i precedenti un meraviglioso equilibrio di scrittura che è frutto giustappunto tanto di esperienza vitale quanto di esperienza “formale”, anche perché non si cada nell’equivoco di una scontata “facilità”, o per dir meglio, “semplicità”, essendo sempre insidioso il vantaggio di ciò che non è che semplice (“Dentro la vita semplice, così è scritto”). Inutile osservare, se non per preterizione, che ciò che è semplice non significa facile.
Cosa, del resto, che il poeta sa dire in maniera evidente con l’ausilio di un’affinità congeniale come quella di Bill Evans, il pianista jazz, e della sua nuova – inventata – “armonia” (ma anche il contiguo Fauré…): “Se tu fossi qui, in questo preciso frangente/ nella quiete esplodente di Bill Evans/ – sempre lui, non c’è affanno che vinca/ la grazia – ti illustrerei/ che sapienza di intrecci in quelle note/ che sembrano piane e invece…”.
Non c’è forse tutto qui, in termini allusivamente meta-poetici? Intanto c’è la “quiete esplodente” che è un ossimoro. Poi c’è il “sempre lui”, ma anche l’affanno che non può vincere la “grazia”, altra parola di alta frequenza in Davoli. E infine ci sono le note “che sembrano piane e invece…”, con tanto di avverbio oppositivo e giunta di aposiopesi, ossia di una sospensione che dice tutto. Potendo il tutto ben valere come modello interpretativo dell’opera stessa di Davoli.
Due le modalità che in una si congiungono. Da una parte la definizione del mondo – dell’universo – di Davoli: la sua collocabilità, la sua collocazione, la sua “residenza” (parola ben incardinabile in una poetica di marchigiana estensione); dall’altro la sua dizione, la sua pronuncia, il suo rapporto cosa-parola, la sua scrittura.
Se badiamo alla prima modalità, non si può sottacerne l’origine nella “terra delle armonie”, la dolcezza collinare del

Maceratese e del Fermano di contro alla maggiore asprezza dell’Ascolano, indugiando su declivi che sanno di maternità, su colline tonde e smussate (“Tu, moto ondoso delle mie colline,/ mare d’erbe dolcissime”): ulivi radi, casali sparsi, terreni pettinati di ocre e di marroni intrecciati ai verdi teneri, ai verdi pastello, all’azzurro mosso e variabile di un mare che in Davoli è presenza materna e paterna, prossimità e lontananza, orizzonte e confine che sale più che leopardianamente all’infinito, come in uno degli interludi in prosa “poetica”; proprio quello che principia: “C’è armonia nel mondo” e che ad un certo punto dice: “radice, identità, appartenenza, sigillo supremo dell’umano; finitezza che cerca in sé l’infinito; precarietà che anela all’eterno partendo dalla propria realtà”.
“Capissi l’eterno/ che c’è dentro il presente”, dicono due mezzi versi di un testo della prima parte, Riletture. Così come l’altrove sta nel dove, che lo suggerisce. Tanto nel felice contraddittorio con Rondoni: “Caro Rondoni, se dunque come credo/ la nostra ricognizione si assomiglia/ ed altrettanto però prende distanza/ forse lo devo alla pianura che abiti/ e al moto ondoso delle mie colline”. Quanto nell’apparente frivolezza del rinvio a Mina – dell’amatissima Mina –: “Sei sempre oltre, nella levità”. O ancora, con diversa estensione e religione, come nel rinvio a Matteo Ricci – il grande maceratese indipeta – che mi fa pensare al libro di Gian Carlo Roscioni, Il desiderio delle Indie: “Amare/ l’attimo prima dell’attimo di andare/ stringendo in un istante d’assoluto”, con quel che segue nel quadretto famigliare e nell’ossimoro finale del silenzio “che scalmana/ dentro uno sterminio fitto di grilli”. Così contiguo al “compatto ristare di baleni” del testo immediatamente successivo.
Chiara in Davoli anche l’appartenenza poetica – dall’amico Pagnanelli all’amico Garufi passando per il critico e poeta fermano Alvaro Valentini – che evidentemente non rinuncia a ben altri affratellamenti e alunnati, se sono stati pronunciati a più riprese i nomi di Luzi, di Sereni, e persino persuasivamente di Fortini (ma io aggiungerei in qualche anfratto, anche un meno chiuso De Signoribus, e in qualche cadenza ritmica in qualche lessicale localismo, un “calviniano” Piersanti). Luzi, certo, il maestro dichiarativamente prediletto, ma – nella sottolineata diversità di voce – anche Franco Loi, per via di una “integrità” segretamente concorde, che va al di là delle immediate parvenze.
Ma siamo con questo alla seconda delle modalità, vale a dire la scrittura. Una scrittura che incide la parola con limpido bulino cercando di sollevare, sì, il quotidiano a misura d’eterno, ma anche il “meraviglioso istante” del titolo al fuoco della sua altrettanto meravigliosa controversia, che soltanto nell’ossimoro si compone. Questione, va da sé, che è sempre di “parole”, se vero è che le parole “sono loro che ogni giorno inventano il mondo”.
E allora quali le parole? A quali discendenze? A quali dettati? Intanto parole che non fanno salti, e che appartengono a una koinè poetica sideralmente lontano da ogni babelismo più o meno mitragliato. Parole, quindi, chiare e per lo più consuete che di tanto in tanto s’inarcano in qualche lieve preziosismo oppure attingono a un repertorio di voci locali, legate più a una diversa pronuncia che non a un lessico divaricato. Parole, pertanto – e parlo di quest’ultime – che fanno macchia leggera, consentono a volte (lo ha notato ancora Franco Loi per il Davoli d’esordio) con una specie di ermetico strascichìo (il primo Luzi, intendo, poi plurimo e diverso, ma anche il Gatto più attento ai risvolti sociali della sua sempre sensuosa dizione.

Nei testi di Davoli, sempre e sempre più, a prevalere è l’immediatezza della comunicazione, il primo livello di una scrittura che procede dall’“occasione” e che mira a una referenzialità ineludibile, ma che in qualche caso anche passa attraverso una potenzialità analogica che si manifesta in salti mitemente quantici, riconducibili a più assorte atmosfere di ascendenza remotamente ermetica (un ermetismo postremo e profondamente rivissuto e ri-usato). Per un verso, quindi, l’incidenza connaturale di un calibratissimo ductus prosastico; per altro verso l’addensamento di un dire più enigmatico e interrogativo, più sinteticamente poetico.
A farne fede anche il lessico che nella sua consonanza a tratti persino dialettale, ci parla di consuetudine e di “normalità”, e che tuttavia s’intride a tratti di parole e modi segnalabili per la loro preziosa rarità (rigagno, pomario, brivida, meraviglio (d’uso non riflessivo), cupore, rancura, s’abbuia, intorta, scrimolo, divieta, obiurga, malure, famuli, viridando, si raccorcia e così via), quando non, addirittura, di parole che paiono convocare una per altro lesta e consustanziale intenzione espressionistica: “V’è l’estro che dipana/ dall’emisfero destro, l’altro aggruma/ ciò che dall’uno scrolla. Disti e torni/ a te da te”. O più ancora: “In un balzo fu uomo e ti conobbe/ lì dove il cuore èrgota e s’azzurra,/ s’abbruna il sangue e srondina. Ma alta/ ne è la gazzarra, rimontante il botro./ Un esplodere d’acque tra le giuncaglie/ e il formichio./ La luna ti recinta dentro il buio”.
Lirica ed elegiaca per eccellenza, la poesia di Davoli – nella sua grazia e nella sua levità, nella sua mitezza – ci invita alla sua voce, che nella continuità del suo farsi e del suo dirsi sa raccoglierci nell’alta consolazione della parola che vibra di verità, che nella prospettiva orizzontale dello sguardo addomestica – con la sua dolcezza collinare – il profitto della più ardua altura.

