
Di Giuseppe Rosato
M’era capitato, quando si era di pochi anni, a ridosso della morte di Ennio Flaiano, di intitolare uno scritto commemorativo “Assenza di Flaiano”, contravvenendo a quanto più generalmente accade, che ricordando e celebrando un autre scomparso si parli invece di una sua presenza: naturalmente come persistenza viva della sua opera e della sua immagine. Assenza di Flaiano, tentavo di spiegare, da intendersi in vario senso: a incominciare dal più elementare, fisico: mancanza dunque concreta dell’amico e della sua parola, della possibilità di ascoltare da lui una chiosa, immagine alla lettura di un evento, magari di quelli che dimostrino come davvero la realtà superi la fantasia portandosi al di là di ogni paradosso. “Vediamo che ne dirà, o scriverà Flaiano”, ci si trovava allora a pensare. Dopo, invece, non restava che chiedersi che cosa ne avrebbe detto Flaiano. Dov’era, ed è, appunto elementarmente, il primo segno della sua assenza.
È pur vero che la suaccennata osservazione, che era di Flaiano, della realtà che supera la fantasia, ha trovato negli anni venuti avanti dopo la scomparsa di Ennio un crescendo di conferme clamoroso. Allo stesso modo la satira, per la quale lui già diceva che non c’era più spazio, vinta a sua volta dall’accettato ridicolo che in tutte le cose presuntamente serie, sembra che abbia chiuso per sempre il suo tempo e il suo ruolo. “I tempi chiedono satira”, aveva affermato Giovenale, ma forse erano, quelli, veramente “altri” tempi: oggi chi se la sente più di far cozzare un’arma così sottile, così nobile, così intelligente contro la refrattarietà di una cronaca e dei fatti che vi stanno dietro, suscettiva non d’altro che di sbigottimento, o di avvilimento?
Flaiano era nonostante tutto riuscito a conservare una certa pazienza, frutto si dovrà dire di una sua resistente speranza che qualcosa potesse ancora ribaltarsi in pro di un più dignitoso impiego dell’amore, della carità, dell’intelligenza. Flaiano scrittore morale, non moralistico, è questo che significava appunto e si può parlare di speranza, in uno scrittore il cui umore sembrava volgere decisamente al pessimismo, o allo scetticismo. Poteva forse scambiarsi per scetticismo lo sconforto, l’amarezza di vedere giorno per giorno perdersi nell’umanità la categoria che sarebbe dovuta esserle propria, si vuol dire appunto la disponibilità ad usare intelletto e amore.
Con accenti costanti di amore parlava il suo “marziano”, paradossalmente dunque un essere venuto da un pianeta non certo accreditato dagli attributi giudicati propri della Terra, giardino presunto dell’universo, grazie alla presenza dell’uomo. Solo da un altro mondo – ed ecco la disperata speranza -, chissà se per manco di civiltà o se per un più compiuto possesso di essa, poteva ormai giungere qualcuno in possesso di qualità che l’uomo non sembra più capace di far proprie, benché le ponga costantemente al vertice degli obiettivi per i quali afferma di operare. Poeta-profeta, Flaiano aveva individuato nella carenza di amore la prima ragione del dilagante disagio all’interno di una società che egli vedeva perdersi dietro una miriade di interessi, di tornaconti, di furberie. E qui diremmo fortunatamente assente, poi, Flaiano, da un tempo di cui egli aveva sì anticipato la lettura, ma che si è venuto rivelando capace di portarsi al di là di ogni più pessimistica previsione dello scrittore.
Assenza di Flaiano, viene ancora da pensare, per contrasto a tutte le altre presenze che le cronache letterarie di oggi ci propongono. A fronte del comportamento di molti che scrivono, per i quali l’impegno maggiore si direbbe che consista nel procurarsi il consenso, con tutti i vantaggi connessi, dunque per una concezione finalistica del proprio lavoro che dovrebbe già contraddire l’essenza, non si può non pensare a Flaiano. Alla sua discrezione, alla sua regola di sottrarsi, al suo credo del rifiuto, al suo dubbio che assumeva le vesti dell’ironia, dell’autoironia in particolare.
Assenza di Flaiano – ancora, ancora – come vuoto di poesia. “Un mondo ha finito di vivere”, egli aveva scritto nella Lettera a Bilbilis, “quando il poeta va via”. Sono versi che parrebbero oggi piuttosto estranei ad una realtà che, al contrario di quanto essi postulano, si direbbe che riprenda fiato, e fervore, e quindi si trovi a vivere a suo migliore agio, proprio quando abbia messo da parte le elucubrazioni del poeta. E poeta Flaiano lo era nel senso più coinvolgente della parola, benché avesse pudore di dichiararlo, al punto di schermirsi dietro affermazioni riduttive, oltre che dietro la facciata emergente a connotare la sua scrittura in versi, l’etichetta si vuol dire di verseggiatore satirico. Rispondendo in merito a questa specifica questione, in un’intervista radiofonica poi trascritta sulla rivista Dimensioni, egli aveva detto: “In fondo io sono uno scrittore satirico che ha un pochino vergogna di essersi fatto definire in questo modo. Perché non credo che la satira possa risolvere nulla. Le mie preferenze vanno per gli scrittori lirici, per gli scrittori che vedono il rapporto tra la vita e la natura, tra gli uomini e le cose, tra gli uomini e il tempo. Ma anche per un sentimento di pudore, ho lasciato che queste cose le facesse chi le sa fare”.
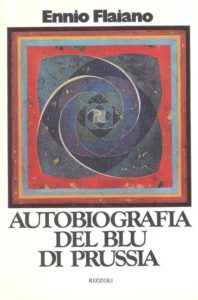 Al tempo di quell’intervista, registrata nel marzo ’72 e dunque pochi mesi prima della morte, egli teneva già nel cassetto la straordinaria serie di versi lirici che però sarebbero usciti solo post mortem, raccolti nel volume Autobiografia del blu di Prussia insieme con gli altri versi satirici ed epigrammatici. Ma Flaiano aveva ipotizzato un volume che accogliesse soltanto la zona lirica della sua produzione di versi, ce ne aveva parlato, proprio nel tempo dell’intervista, come uno dei pochi progetti che avrebbe voluto condurre in porto. Ma che quei versi fossero poi pubblicati in stretta mescolanza con gli altri, epigrammatici appunto e consoni alla verve più generalmente accreditata dello scrittore, forse a lui non sarebbe infine dispiaciuto, nell’ottica proprio della sua naturale tendenza a mimetizzarsi, oltre che della convinzione che farsa e tragedia dovessero convivere anche sui libri, così come nella normale vita di tutti i giorni.
Al tempo di quell’intervista, registrata nel marzo ’72 e dunque pochi mesi prima della morte, egli teneva già nel cassetto la straordinaria serie di versi lirici che però sarebbero usciti solo post mortem, raccolti nel volume Autobiografia del blu di Prussia insieme con gli altri versi satirici ed epigrammatici. Ma Flaiano aveva ipotizzato un volume che accogliesse soltanto la zona lirica della sua produzione di versi, ce ne aveva parlato, proprio nel tempo dell’intervista, come uno dei pochi progetti che avrebbe voluto condurre in porto. Ma che quei versi fossero poi pubblicati in stretta mescolanza con gli altri, epigrammatici appunto e consoni alla verve più generalmente accreditata dello scrittore, forse a lui non sarebbe infine dispiaciuto, nell’ottica proprio della sua naturale tendenza a mimetizzarsi, oltre che della convinzione che farsa e tragedia dovessero convivere anche sui libri, così come nella normale vita di tutti i giorni.
E così, nel citato volume Autobiografia del blu di Prussia, uscito nell’ottobre del ’74, ecco affiorare i versi di Diciassette marzo millenovecentocinquantanove, e di Dialogo per provare una penna nuova, e poi risolutivamente le dodici lasse del poemetto La spirale tentatively, dove, vinta ogni dichiarata schermatura, viene fuori il Flaiano poeta, che guarda alle radici la sua pena di uomo e la racconta, come a sé stesso.
In quei versi c’è non tanto la presunta “altra” faccia di Flaiano, ma forse il solo e vero Flaiano, qui finalmente privo delle consuete difese. La dimensione che se ne configura non può non sorprendere, certo; ma essa si lascia intuire sortita dal fondo della necessità – a un certo punto giudicata non più differibile – di restare solo dopo tanta continua evasione dalla solitudine: si vuol dire solo con la propria storia intima, come se tanti voluti antidoti ne avessero di continuo respinto o rinviato l’incontro.

Soleva dire Flaiano di non poter viaggiare più in treno perché non era più capace di rimanere solo, senza che nient’altro gli fosse possibile fare, a tu per tu con i propri pensieri; nel timore che questi dovessero condurre a chissà quali rendiconti. Sull’aereo invece, diceva, non fai a tempo a salire, accomodarti sulla poltrona, slacciarti la cintura, ed ecco che già la voce dell’altoparlante ti invita a riallacciartela perché l’atterraggio è prossimo.
La metafora è trasparente: finché aveva potuto, Flaiano aveva scelto di viaggiare in aereo, riportandone impressioni di viaggio veloci, brillanti, leggere: ed era stata cosa frequente, o meglio era lui che ne aveva a lungo accreditata una propria misura che non era però sicuramente la più vera. Poi, come se a un certo punto non avesse potuto evitare di prendere il treno, e viaggiarvi lungamente da solo, ecco le pagine del rendiconto, struggente, impietoso. Leggiamo per brevissimi capi, da La spirale tentatively:
Se guardo a quello che ho fatto è povera cosa,
un continuo rimestare le prove
di un inqualificabile crisi di volontà,
il rinviare, il compromettere, il soprassedere,
tutto ha il senso di una finzione assurda,
la futilità di aver vissuto ai margini
fuori di ogni corrente decisiva e costruttiva,
contro me stesso, gli altri, le donne soprattutto,
uno sbaglio volutamente barocco
che si pasce delle sue stesse evoluzioni…
(…)
eppure alcuni segni ci avvisano continuamente
che la strada da percorrere è già tracciata
nelle sue linee essenziali. Sono ammesse
deviazioni volubili per sentirsi padroni
del destino, che invece è già segnato nel carattere
cioè nella capacità di vedere quei segni
e di sentirne il particolare significato.
Sono anche ammesse interpolazioni nel testo,
per la necessità di continuare lo spettacolo,
ma nel clamore della risata può succedere
come in certi banchetti della Bibbia
di scoprire controluce la filigrana del segno…
Si direbbe davvero un Flaiano spiegato a sé stesso, oltre che naturalmente a noi. E poi la puntuale, analitica contemplazione della morte, dopo che con il primo infarto se l’era trovata di fronte:
Ma ora si tratta di considerare il punto
della nostra morte, e questo ci trova sempre
curiosamente impreparati, persino scettici,
non sembrandoci possibile che un giorno
le stesse cose che oggi ci annoiano non debbano
continuare ad annoiarci, che tutto finisca come
nel nero volo del sonno, quando ci cadiamo.
(…)
Non so ancora vedere la stagione di quell’anno
ma penso al tardo autunno, la salita dell’inverno…
Versi profetici, anche, questi ultimi. Ma rileggerli oggi, quei versi, e naturalmente nella loro interezza e densa complessità, dopo che in tutti questi anni un po’ di tutto è successo alla poesia, ovvero non è successo nulla se è vero che nei confronti di essa resta nel grande pubblico il medesimo atteggiamento di diffidenza, o peggio di indifferenza, si può in qualche modo avvicinarsi a capire di quale ruolo avrebbe dovuto continuare a vestirsi la poesia perché conservasse un margine almeno di attiva presenza.
Coinvolgendo il lettore nell’umanissimo scandaglio che fa della propria esistenza, un poeta che non si riteneva tale offre un esempio di ciò che si dovrebbe ancora chiedere alla poesia. Lo fa con le sue scabre pagine, aliene da qualsiasi ornamento, da qualsiasi artificio, da qualsiasi arbitraria bravura o spericolatezza linguistica. Non credo che si possa prescindere da questioni che qui si lasciano solamente implicite, se si volesse tentare di spiegare la sostanziale assenza della poesia.
Assenza della poesia già in termini concreti, di scomparsa pressoché totale di suoi lettori – mai un volume di versi compare nelle classifiche dei libri più venduti -, come se venisse riconosciuta o sancita ufficialmente, quasi fosse un assioma, la distanza della poesia dalle urgenze del mondo reale; nella convinzione dunque che la poesia in sé, con il suo solo porsi, non potrà mai rifare il mondo, produrre uscite alternative dalle angustie che lo governano.
“La poesia è una vita di scorta”, aveva anche detto Flaiano; ma è da credere che ad altre e ben più concrete vite alternative oggi generalmente si aspiri, fatte di beni tangibili, qualora fosse praticabile un risarcimento da tutto ciò che giornalmente l’esercizio dell’esistenza ci chiede.
E ancora un’altra frase di Flaiano torna a insistere nella memoria: “Quando la scienza avrà messo tutto in ordine, toccherà al poeta rimescolare di nuovo le carte”. A quale poeta? O, diciamo per estensione, a chi o a quanti di coloro che orbitano nel sempre più complicato, indecifrabile universo della scrittura? Probabilmente non a chi, scrivendo, si premuri innanzitutto di coltivare la propria immagine per edificarsene una “fortuna” in termini di successo e conseguenti concreti ritorni, ricorrendo a sistemi che già facevano lo sdegno di Flaiano. Si dirà che tali criteri sono entrati nel novero delle cose normali, tant’è che le cronache – letterarie o mondane – ne parlano senza più mostrarne alcuna meraviglia; e dunque come se già tutto, di questa zona giudicata futile, e improduttiva, della nostra vita, fosse comunque destinato a cadere – come in realtà vediamo cadere – nel disinteresse e nella triste indifferenza. Ma noi ci si vorrebbe ostinare a non pensarlo che anche il poeta, anziché proporsi di rimescolare le carte, abbia scelto di farsi organico al gioco, purché proficuo; e che le parole di Flaiano siano destinate a rimanere un monito inascoltato, tradito sempre più il suo sogno dalla realtà che lo sommerge, che ne sancisce la definitiva assenza.
__________________
 Giuseppe Rosato vive a Lanciano (CH), dove è nato nel 1932. Ha pubblicato numerosi libri di versi, in lingua e dialetto, a cominciare da L’acqua felice (Schwarz, Milano, 1957), di narrativa, di prose, di aforismi, oltre ad operine satiriche e parodistiche. In ambito poetico, si segnalano inoltre i recenti Le cose dell’assenza (Book Editore, 2012) e Conversari (Carabba, 2014 – prefazione di Giovanni Tesio). Critico d’arte per la RAI, di cui ha curato servizi culturali e programmi radiofonici, ha dato alle stampe monografie su artisti contemporanei. Oltre ad aver diretto le riviste “Dimensioni” e “QuestArte”, ha collaborato stabilmente con la rivista “Ciminiera”. Vincitore di premi come il “Carducci” e il “Pascoli”, nel 2010 è stato insignito del “Frentano d’oro”. Favorevolmente recensito da scrittori e critici come Pier Paolo Pasolini, Franco Loi, e Franco Brevini, Rosato fu in stretti rapporti di amicizia con Ennio Flaiano; il loro scambio epistolare è stato pubblicato in E. Flaiano, Lettere a Giuseppe Rosato 1967-1972 (Lanciano, Carabba, 2008).
Giuseppe Rosato vive a Lanciano (CH), dove è nato nel 1932. Ha pubblicato numerosi libri di versi, in lingua e dialetto, a cominciare da L’acqua felice (Schwarz, Milano, 1957), di narrativa, di prose, di aforismi, oltre ad operine satiriche e parodistiche. In ambito poetico, si segnalano inoltre i recenti Le cose dell’assenza (Book Editore, 2012) e Conversari (Carabba, 2014 – prefazione di Giovanni Tesio). Critico d’arte per la RAI, di cui ha curato servizi culturali e programmi radiofonici, ha dato alle stampe monografie su artisti contemporanei. Oltre ad aver diretto le riviste “Dimensioni” e “QuestArte”, ha collaborato stabilmente con la rivista “Ciminiera”. Vincitore di premi come il “Carducci” e il “Pascoli”, nel 2010 è stato insignito del “Frentano d’oro”. Favorevolmente recensito da scrittori e critici come Pier Paolo Pasolini, Franco Loi, e Franco Brevini, Rosato fu in stretti rapporti di amicizia con Ennio Flaiano; il loro scambio epistolare è stato pubblicato in E. Flaiano, Lettere a Giuseppe Rosato 1967-1972 (Lanciano, Carabba, 2008).
