
Come si affronta un viaggio salvatico? Gianpaolo G. Mastropasqua, classe ’79, è poeta che sembra praticare il cammino da secoli. La sua poesia fa eco ai Lorca e Donne della storia, senza risparmiare incursioni, più o meno apertamente stabilite, con la Beat, in particolare con il Kaddish di Allen Ginsberg (si senta il ritmo, la verticalità del dettato, che sempre si alza, sempre si carica). La poesia di Mastropasqua è polifonica, oltre che corale. È, cioè, fatidica e giustapposta, determinata oltre che composita, intrecciata, complessa. Non è una poesia per tutti, ma sembra già ricordarlo la terza di copertina, dove si parla della collana “Il drago verde” della Fallone editore, diretta da Michele Zizzi, e ben chiara sulla linea alta che vuol tenere. Parliamo della aristocrazia della poesia, quindi di una poesia che non è né semplice, nel senso di diretta, né retorica. No.
In Viaggio salvatico il poeta imprime la forza del suo pensiero nella poesia, traducendo dai suoi testi le coordinate per dirigere l’intera opera verso concatenazioni di stelle, quindi di concetti, di intuizioni. Gianpaolo Mastropasqua affresca le pagine, ce ne rende la vastità in questo “eccesso di parole” che non è mai, quasi tenendo a mente la massima luziana, “eccesso di Parola”. Questi versi sono, in qualche modo, la prole; ma ancor prima gli amici; ancor prima una voce primordiale, originaria, antidiluviana, che sostiene tutto il discorso.
“La realtà è più della somma delle parti”. Quello che ci porta a fare l’autore è leggere poesie, nel senso, quasi imposto dal taglio di ogni brano, di frequentare il linguaggio utilizzato, fino a diventarne padroni. A dire il vero si rimane sempre un po’ fuori, ammirati e anche intimoriti da questa nuova cosmogonia, da questa istanza profonda del reale che si fa più che reale, che si innalza ad architettura, a sinfonia, ovvero scardina il suono dal flusso naturale dei rumori, per renderlo qualcosa di attraversabile. Ecco noi attraversiamo ciò che della realtà è stato preso; ciò che dalla realtà arriva alla pagina in una forma contratta, spremuta e sintetica.
Discutere di questa raccolta non è facile, ma non è per paura del compito che ho scelto di evitare un’analisi capillare, specifica, aiutandomi magari con testi o con la prefazione, attentissima, di Giuseppe Conte. Ma, piuttosto, è quasi un’ipotesi di obbedienza, di ascolto totale verso questo cosmo, questo ex caos che trova, in un lavoro decennale, una compiutezza e una raffinatezza rarissime nel panorama poetico italiano.
Voce che si sostiene da sola, voce che affama nel propagarsi, la poesia di Gianpaolo Mastropasqua riscopre la complessità in ordini espressivi di grande sapienza, costruiti, è il caso di intendere letteralmente, ad arte. Ma ancora di più è una certa rotondità, una certa perizia, una certa attenzione musicale a stabilire il valore di questa ultima figlia (perché, io credo, che questo libro non possa essere figlio). Figlia dalle braccia assenti e dallo sguardo inviso ai più. Figlia che si sfracella nella strada, ma che, carica di energia, di fiamma, sbriciola il terreno intorno. La poesia di Mastropasqua è questo: una vena sapienziale concentrata in una potenza romantica e maledetta, una poesia mediterranea, che sa espandersi, che sa farsi epica quotidiana. Una grandezza e una spinta alla grandiosità che suggeriscono uno spirito titanico. Eppure, c’è qualcosa che ti inchioda con dolcezza, come una premura di maestro che t’illumini il cammino.
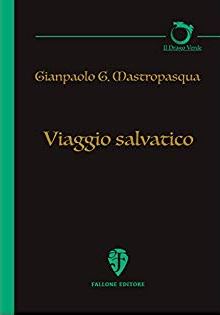
Alcune poesie estratte dal libro:
dalla sezione Scherzo per uomo e orchestra
Scorpione in acquario
Nella camera del grido misurò la potenza
della perdita, l’acquisizione vocale
e sanguigna, il dolore nascituro,
la gola che capì l’ossigeno e l’immobilità
del mondo, la mancanza di rotazione
reciproca, l’assenza della danza;
solo volti animali e alieni, facce stupide,
masse o massi di buchi bianchi e il presagio
della somiglianza, dell’essere parenti
stretti, o rumore che mostrava i denti
e rubava il pollicino, adorato ossicino
ambito da cuore e fiati, nell’orchestra
materna, fiutava l’amore, la traccia
epidermica, la madornale voce.
Dopo molto lavoro e tragica luce
l’ombra covava, tra l’umido e il vapore
e addome l’abbandonò; mostrò a tutti
la nuova forza e il regalo, lo sforzo,
tutto quanto già di marcio e di umano
aveva in corpo: fu fare l’universo, farsi
a pezzi, lasciare le orbite e gli occhi appesi.
*
dalla sezione Sudaria
Parto rurale
Marcia che svegli l’erba sulla nuca e batti
tra le gravine sorvegliate dal bracciante lunare
con la falce millenaria e metà faccia bruciata,
passeggiano in campagne uomini secolari
sbucano dai pozzi o dalle grotte alberate
con i nomi grezzi e le ossa dolcissime,
hanno doline di figli, foreste di nipoti
e danzano in amore sui colli caveosi,
a volte richiamano dai timidi torrenti
o dai buchi neri delle querce siderali
si prendono cura dei poeti grillai
mentre cianciano coi cirri o scrivono l’aria
vegliano i nidi e la fame dei corvi,
quelle barbe imberbi di dèi divoranti,
o il sarcasmo rampante delle gazze ladre
che ammaliano i passeri per depredarli;
si inoltrano nel solco dei sassi per scivolare
nell’infanzia sonora di un presepe vivente
dove in vasi comunicanti nuotano paesi
con voci labirintiche e madri di pietralacrima.
Sono i reali lettori del suolo, i rimasti,
guardiani mormorei della lingua dei mondi,
gli altri mammiferi sono andati in letargo
con la pancia ripiena e i neuroni spenti
qualcuno ride dal tafanario e sfiata silenzio
qualcun altro è già masso da un pezzo.
*
L’ultima traccia il figlio
Cigno di carta disarmata madre
distesa sull’acqua gonfia di morte
un pennello d’astri tra dita ovattate
dipinge la vita sul vetro diluviato.
Le onde materne dondolavano la culla
insegnando l’oceano dove si addormentava
il crepuscolo, quando parole disegnavano
l’universo delle somiglianze nella mente.
Regina del pianto atomico abbandonata
in un lago di sillabe sciolte, mio padre
e i padri dalle ombre imponenti furono degni
del tuo seno, ma questi figli oramai dormono
privi del gene, senza labbra. Sulla tua fronte
la sera non può specchiarsi e il giorno non ha ore
per baciarti, io selvatico visionario inseguo
le tue pupille, nuvole fisse nel profilo lunare,
l’ultimo lupo si estingue da tempo, restano
i meticci netturbini, orfani di luce e grazia
che brancolano nel buio, digrignando i denti
per raccogliere l’aria ignota che disperdesti.
E quel vento arido dove più non volano
lucciole o filastrocche, ricorda l’aroma
di un corpo vivo, murato, tra Ovest
ed Est, il salice scalcia tra le mani
attende il fiume degli occhi quiescenti,
l’anemone tace, l’eredità è una lacrima.
*
dalla sezione Adagio limbico
Piazza degli eroi
Ci trovammo nella piazza imbandita della sera
nel nucleo di una tavola meccanica
come tante posate volanti, come macchine scolpite
nel capodanno preistorico della fame: cigolavano
le moire dell’equilibrio, le muse strepitose
del ferro, come lance definitive, come teoremi
a orologeria, prima dell’ultimo canto nuziale
vagavano a folle i mulini a vento, le imprese ruotanti
di una storia che da un futuro voleva essere
raccolta, raccontata, come una bimba! E scoppiava
in lacrime d’argento, fiorivano i tarli argentini
sfinivano nell’estasi come il diavolo del passo
e smarrimmo l’alfabeto nella folgore cenerina
ma la tecnica non bastò a disarmare il sogno
la festa è un passaggio fossile, un furto della polvere,
un ronzino che acceca la corsa, una morte accesa.
(nota: rappresentazione urbana del “Don Quijote” del Teatro Nucleo argentino)

