
Per tentare di restituire una lettura critica dell’ultimo libro di Stelvio di Spigno, Minimo umano, edito recentemente da Marcos y Marcos, sono necessarie alcune soste nei dintorni del testo, in particolare nella citazione in apertura tratta dal De docta ignorantia di Niccolò Cusano. Il testo, che contiene alcuni indizi a mio parere fondamentali sul significato del libro e del suo titolo, è il seguente: “Nel movimento, infatti, non si può pervenire al minimo assoluto, come è un centro fisso, perché il minimo necessariamente coincide col massimo. Il centro del mondo coincide con la circonferenza. Ma il mondo non ha circonferenza”. Cusano, nello stabilire nella sua opera che la terra non è il centro dell’universo (che per lui coincide con Dio), afferma l’uguaglianza tra minimo e massimo, tra centro e circonferenza, in un immaginario geometrico che sembra contraddire se stesso nelle sue fondamenta. Questa idea geometrica della coincidenza degli opposti e dello scardinamento del principio di non contraddizione sembra essere, a mio parere, una delle chiavi di lettura del libro e del titolo.
Si potrebbe infatti riassumere la ricerca di Di Spigno in questo libro come il tentativo della riduzione dell’uomo al suo minimo, della progressiva erosione e sottrazione di quello che rende un uomo tale fino al raggiungimento del nucleo centrale della sua essenza, che poi sarebbe il suo massimo. Questo processo di depurazione delle scorie esterne che risultano dannose al processo (alchemico?) di purificazione dell’uomo fino al suo minimo potrebbe ricordare – almeno per chi scrive lo ricorda – l’esperienza rilkiana del Malte, quell’esercizio di apprendimento di una modalità dello sguardo capace di sublimare il mondo visibile dopo averlo radiografato e ridotto all’osso per poi incorporarlo in uno spazio intermedio tra la vita e la morte, in un eterno invisibile che è il fondamento della sua visibilità. Per Rilke – e, come si tenterà di mostrare, anche per Di Spigno – questo spazio intermedio è il “regno” della poesia. Prima di lasciare l’avantesto e finalmente entrare nel libro vero e proprio, sembra importante esporre due avvertenze. La prima riguarda il particolare coté di autori implicitamente o esplicitamente menzionati nel testo: oltre ai nomi dei contemporanei Silvia Bre, Mario Benedetti e Franco Buffoni, una traccia sotterranea del libro è costituita da scrittori appartenenti al periodo umanistico (il Cusano di cui si è parlato sopra, il Leonardo che figura in copertina), a quello del Seicento (Keplero, citato in esergo di una poesia, e Cartesio, che fa capolino in tutto un lessico anatomico-metafisico) fino al Leopardi più sensista. La seconda avvertenza riguarda la struttura del libro: le sette sezioni in cui è diviso richiamano quella circonferenza senza centro evocata dal Cusano, nel senso che il centro del libro è sfuggente. Non sembra esserci infatti una vera e propria direzione che guidi lo scorrere dei versi, un punto di attrazione. Le varie poesie si intrecciano una dopo l’altra in una serie concatenata (si potrebbe addirittura azzardare di leggere la struttura di Minimo umano come un poema organizzato secondo coblas capfinidas, un racconto in lasse – le singole poesie – legate alla successiva da un elemento comune che torna con variazione minima) che fa pensare ad un percorso da attraversare in maniera libera, senza una specularità fra sezioni che definisca una organizzazione per settori chiari. Quello che quindi si tenta ora è uno dei tanti attraversamenti possibili a cui si apre il testo.
La prima sezione, Preludi, si apre con una poesia dedicata ad Alfred Schnittke, compositore russo morto alla fine degli anni Novanta e famoso per il suo riutilizzo, insieme alle moderne forme della musica seriale e dodecafonica, delle forme del Settecento (il concerto grosso): “Tu che facesti la riforma tonale / a partire dai tuoi sensori remoti, / sapevi e nascondevi che solo andando indietro, / con un diluvio di archi e applausi campionati, / c’era salvezza, se non totale, di una voce / che prenda ancora vicenda con l’umano […] ti scrivo non per lode, né per ringraziare, solo perché mi hai svelato una via da seguire” (p. 9). I versi citati torneranno più avanti data la loro importanza strutturale. Variante lombarda e Griselda dei Balcani chiudono la sezione. In particolare, l’ultima poesia contiene in sé, anche a livello “performativo”, il tono dominante dell’intera raccolta, una dolorosa e frenante incertezza che sfida il linguaggio: “E invece accade che. Ora dovrei dire cosa accade, / ma non succede altro che una misteriosa / archiviata solitudine, che punta dritta alla trachea” (p. 13).
La seconda partizione del libro, Versi morali, comincia a mettere in pratica, con una logica spietata e leopardianamente disillusa (il nome di Leopardi fa capolino dietro la mezza citazione delle Operette), il processo di riduzione al suo minimo dell’uomo. L’esistenza è pervasa da un Nulla ( “Il Nulla è ogni giorno più forte” recita l’esergo da La storia infinita di Petersen) che attanaglia ogni momento felice, che lo costringe ad estinguersi e a lasciare spazio ad un Male che è inesistenza di Bene. Dapprima il bene è parziale (“Non ho scovato il bene / femminile, per quello di Dio / ci lavoro ogni ora” – p. 17), poi sembra sempre più estinguersi (“neanche tu sei più la prova che il bene esiste” – p. 20) per poi arrivare, nella poesia dedicata a Mario Benedetti, a una lucida e controllata disperazione (“eremita murato vivo al tavolo da gioco / o anatomico”; “tanto il male è lo stesso, / lo stesso il lamentare”; “Intanto la carta esce ancora vincente, / io la scambio per una pozza o una stalla, / una morte possibile purchè sia a ore”: “la vita non manca, ci manca” – pp. 23-24) che assume toni di maledettismo.
Il pedale materialistico-nichilista sembra accentuarsi ancora di più nella sezione Elegie finali. La dimensione materiale, insieme a quella morale e metafisica, sembrano del tutto impossibili senza il marchio del fallimento e della mortificazione. Sveglia anticipata mette in scena (grazie alla citazione dal Filocolo del Boccaccio) una rappresentazione donchisciottesca e malinconica dell’autore e dell’uomo in generale. “Vedi che sto scomparendo, / insieme a me la civiltà dell’onore fraterno, / del calore, dei corpi saldi, del cielo, / la gara a essere umano, anche un minimo, / la sabbia, il gesso, l’argilla, la fortuna / delle guarnacce, delle mani che si allentano” (p. 31). La chiusura di una stagione storica e al contempo antropologica riduce tutto a materia, a sostanza da indagare scientificamente, come il Leopardi “mente atomica sull’uomo fatto nulla” (p. 32), con una logica implacabile e disperata. A questa atomizzazione fa da controcanto, in successione immediata, un focus più marcatamente indirizzato verso la dimensione corporea. La disperazione ora passa per i tessuti, per le ossa: “Altre carestie aspettano la sorte / di subire e sapere che eravamo mani, / braccia, toraci, pubi, crani, / messi a disposizione di un amore latente” (p. 33), la “fine quasi amica” acquisisce un “peso, la dignità, le conseguenze” (p. 36). Il minimo umano, più che un pensiero nichilista sul mondo, è un nichilismo incarnato, il corpo privato della sua finalità, il deperimento dell’organismo e la sua decomposizione in vita. E qui, al picco più basso, si apre il rovescio del minimo, la sua apertura verso la sublimazione in massimo. La poesia che chiude la sezione, indicativamente intitolata Corpo, dapprima lamenta l’invecchiamento e lo sfaldarsi della forma (“adesso impara il disamore, / la posa declinante, la frattura, / non sarai più l’immagine di Dio / che da sempre racchiudi a protezione”) ma poi inaugura, con un termine fino ad ora non utilizzato, “anima”, una dimensione di apertura verso un’altra dimensione che sembrava impossibile: “Ma forse [corpo] anche tu tornerai nuovo / quando l’anima si staccherà da te / e andrà lì dove tutto si crea, / tu che non vuoi morire, / col tuo vestito a festa / carico di rammendi, / brillerai per le strade” (p. 38).
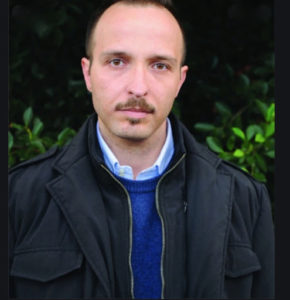
Con l’ingresso dell’anima si apre la sezione Terra e cielo che, più che risolvere le tensioni sviluppate nelle poesie precedenti (in verità abbastanza costanti, sia a livello tematico che stilistico), sembra trascendere la mera materia per approdare a una metafisica che pare risollevare il destino umano, trovargli un centro. Tuttavia, il binomio terra/cielo fa il pari con quello corpo/anima (Cartesio, come si vedrà, è al centro della sezione, sia nella versione vulgata che in quella più criticamente approfondita) e la commistione fra le due si fa evidente in versi come “Ma l’anima che ho dentro, che mi nutre / a conati di asma, chi la solleverà?” (p. 43). L’anima porta con sé il riferimento a una ispirazione cristiana, rintracciabile in versi come “tu solo riconosci, dove / e quando la parabola del cielo / e della lingua si ferma in noi, in che punto / e perché mai” (p. 44). La parabola, oscillante sul piano cartesiano in contrapposizione alla statica circonferenza, si sostituisce al cerchio e la poesia sembra trovare una diversa funzione: “La mano trema cercando questi versi. / Con loro, negli anni, ho fabbricato / il sortilegio di un ricordo futuro. Mi pare / di vederla: poesia come ruota di mulino / che accecava la sorte e portava refrigerio” (p. 45) Ritorna qui la via segnata da Schnittke, l’andare indietro come avanzamento (il ricordo che è paradossalmente futuro) e, inaspettatamente, il Leopardi della poesia che aggiunge un filo alla “trama brevissima” della vita. Senza soluzione di continuità (secondo il principio della coblas capfinidas di cui si accennava in apertura) il ricordo torna nella poesia successiva: “La vita continua negli ossari / o nel ricordo? Nella storia o nelle steppe? / Con noi o senza di noi?” (p. 46) e l’allargamento dal corpo al mondo in senso universale e cosmico (preparato dal Keplero citato in epigrafe alla poesia) torna nella successiva Quasar, in cui la fusione tra materia, mondo e uomo sembra trovare una possibilità di esistenza, facendo coincidere il minimo del corpo umano al massimo dell’universo inteso chimicamente: “sarà fatto il nostro nome palmo a palmo, / sorgeremo fra estuari, laghi e fiumi / a vita di carbonio o a canto delle stelle” (p. 48). La poesia che determina una ricapitolazione sul rapporto fra corpo e anima, fra minimo e massimo, fra il Cartesio dualista e il Cartesio riletto dalla fenomenologia francese di Nancy, secondo cui “parlando del corpo, parliamo di ciò che è aperto ed infinito, di ciò che costituisce l’apertura della chiusura stessa, l’infinito del finito stesso” e secondo cui l’anima rappresenta “il corpo fuori di sé”[1], è Dilemma: “Eppure ti dico che il mondo / così come è fatto, detto, eletto, / non può sentire l’inverno come noi umani, / la spinta ad andare indietro, il ricordo come chiave / pineale che non apre se non il diaframma eterno / del dolore” poi “non è malanno di organi e ossa, / ma una scossa che nel fondale impenetrabile / al pensiero innesca qualcosa di immortale […] e invece è quella parte di noi che è perenne / e non può svanire, non va a perdersi anche lei” (p. 50). Il corpo rammemorante, che prova dolore, grazie a questo dolore si connette a tutto l’universo, fa corpo con il creaturale che pervade la creazione. Il minimo si fa massimo, il centro è la circonferenza, il corpo è l’anima. Questa oscillazione di termini (originalissima e dal vago sentore luziano, in particolare il Luzi della sezione Bruciata la materia del ricordo di Per il battesimo dei nostri frammenti) trova il suo punto nevralgico nella figura di Cristo, evocato direttamente in Mozione evangelica e poi in Incarico e richiesta: “Tu chiedi, / come Cristo nel Getsemani, di non percepire / la morte di chi con vigore ti ha amato […] Allora prega soltanto” (p. 58). Il richiamo alla preghiera sembra in qualche maniera bloccare la spinta “panica” che aveva attraversato gli ultimi testi, e un ulteriore freno è dato dal verso “Parlare non è un ponte che si prolunga in cielo” (p. 59). La sezione si chiude con un “aspetto il giorno della risurrezione”, a mo’ di abbandono della pretesa della poesia di essere il centro dell’uomo. Altro alla poesia non si può chiedere.
Altro rispetto al reinserire nel visibile l’invisibilità dei morti, dei ricordi, dell’oscurità che è il centro della sezione Il mondo estremo. Qui lo sguardo si allarga anche agli altri, alle altre persone, l’io inizia a collegare “la Croce degli Annegati nella piazzetta / e il buio corallo dei fondali marini” (p. 65), a dire non solo il dolore personale ma quello generale che percorre il mondo e che si imprime con un marchio esistenziale nell’umano: “Provo a dire questa furia che è vivere, / l’assottigliarsi della mascella di sorriso in sorriso, / l’aria fredda che fa spessa la pelle in un abito di cera, / e questo morire che è in tutti, da decenni” (p. 69).
L’allargamento dello sguardo procede nell’invisibilità dei defunti cari, di chi scompare da ogni dove ma non nella memoria. La vita facile è una riflessione sul ricordo e sul legame che si apre nel singolo con un’altra dimensione. La sezione Congedi, di due poesie, chiude il libro nel segno della morte e della rimemorazione. Il viaggio, dal corpo all’anima, dal presente al ricordo futuro, dalla terra al cielo e viceversa si chiude qui, in un profilo di donna “esistita / nel delirio di pensarti eterna” (p. 85), in un paradosso che conferma l’adagio di Cusano citato ad aperura del libro. Un percorso ardito e impervio, quello di Di Spigno, inedito nel panorama contemporaneo, specie a livello di complessità strutturale e di “pensiero poetante”. Un percorso che sembrava non essere richiamato da alcun centro ma che è stato attratto dal suo stesso procedere in tondo.
***
Stato delle cose
L’epilogo della tempesta
fu che tu, reclinata nella morte
che ti permeava
ogni pensiero, rarefatta e abbuiata,
ti allontanasti
dalla stazione di Latina
quasi in incognito.
Lì visitavi l’ospedale, sempre in cerca
di quella stessa morte
che vedevi tra corsie e camerate,
bella, insana e taumaturga,
come allora ti credevi – ti amo più
che posso, bambina mia mai nata, anima
abortita, raccolgo per te piastrelle e putrelle,
mentre il cantiere del nostro futuro si recide.
Provo a dire questa furia che è vivere,
l’assottigliarsi della mascella di sorriso in sorriso,
l’aria fredda che fa spessa la pelle in un abito di cera,
e questo morire che è in tutti, da decenni,
in un tempo scellerato e pazzo, come se
l’esistenza fosse un paesaggio
a tutti pervenuto e confinato altrove.
Una stringa di fumi e graminacee
si stringe a una galassia equidistante, a un’ossessione
generale, mentre l’umanità svuota
di se stessa ogni destino, anche il più bieco,
anche il più assurdo e declinante,
come una fanteria di ritorno
da una guerra mai dichiarata,
a interi popoli nascosta e ipnotizzata.
Scontro
Bicchieri messi a tacere nella notte.
Rivoli di pioggia che fuoriesce dai canali.
Don che ha vinto un figlio alla lotteria della natura.
Piccoli segni, quello che è dato avere.
E c’è una barriera estranea, la tua mente,
che vuole dominare e non ascolta.
Consumi donne per dire che vivi. Prendi libri
per scrivere altri libri, invece avanza
senza protezione, comincia a guardarti le mani,
fai un collegamento
tra la Croce degli Annegati nella piazzetta
e il buio corallo dei fondali marini.
Ho perduto la testa quella sera. Volevo essere
ovunque e correvo, l’auto ha sbandato,
tutto è andato a fondo. Quella vitalità
era razzia di un sogno. Solo il dolore
è stato vero. E la vergogna, tremenda,
mi ha fatto rialzare e stare qui, questa mattina,
nel bosco di una strada senza nome,
a correre tra alberi e radici, fango e pori aperti,
metà del mio corpo mai sentito,
l’altra metà preda dell’orrore.
[1] Jan-Luc Nancy. Indizi sul corpo, Ananke, Torino, 2009, pp. 65, 70,
