“la scrittura è scritta ma
la rappresentazione è necessaria”

Su quella che ormai è diventata la mia scrivania di scorta (ne ho due, una nella casa di famiglia, l’altra in quel di Padova dove ormai vivo da anni), probabilmente cadendo da due pile di libri diverse, si sono accoppiati due librini completamente dissimili all’aspetto, uno bianco l’alto nero. Entrambi però, una volta aperti, si rivelano più vicini di quanto possa lasciar credere la diversità del titolo e della copertina. Il primo – con la copertina nera – è un libro dell’immancabile Mario Luzi ed è La passione (Garzanti, 2014, pp. 80, euro 8), una serie di poesie scritte per la via crucis al Colosseo del 1999; il secondo – il bianco – è un volumetto di Claudio Pasi uscito recentemente per la collana A27 di Amos Edizioni e si intitola Nomi propri (Amos Edizioni, 2018, pp. 60, euro 12). Il primo, dal titolo, è esplicitamente il dramma della crocifissione, una sorta di dialogo a una voce fra Cristo e il Padre, che mai prende la parola. Il secondo libro, invece, si apre – dopo una poesia introduttiva – con una suite di 14 poesie intitolata Via del dolore. Il riferimento, passando per il gergo medico secondo cui la via del dolore è il canale nervoso che comunica il dolore alla corteccia cerebrale., è alla via crucis, all’agonia del padre dell’autore, alter Christi. Sono quattordici poesie in cui, dall’esordio della malattia fino alla morte del padre, Pasi accosta la Passione di Cristo a quella paterna.
Ecco cosa accomuna questi due librini; essi sono (quello di Pasi solo nella prima parte) riscritture del testo biblico, reinterpetazioni drammatiche della rappresentazione biblica. È però interessante notare come, più che di rappresentazioni, qui si parli di messa in opera di un testo, di un dramma che viene performativamente agito e vocalizzato. Ancora più interessante è notare come, per dirla con Wittwoker, il simbolo occidentale per eccellenza, la croce, migri dalla sua configurazione statica e tradizionale (alias “la croce sta per il sacrificio di Cristo che promette la risurrezione”) ad una più umana e pragmatica aderenza alla vita degli uomini.
Questo incrocio di notabilia, che adesso verrà più esplicitamente dipanato e mostrato, mette in moto una serie di riflessioni sulla potenzialità della lingua poetica (metonimia per l’uomo) di riscoprire la sua aderenza ad una tradizione che, lungi dal soffocarla o dall’angosciarla (si veda il magistero di Harold Bloom), la apre al suo destino, la riconsegna alla sua radice prima, quella di essere una parola capace di fare qualcosa, di creare sensazioni o i presupposti logico-linguistici per lo sviluppo del pensiero. In definitiva, approssimando un abbozzo di teoria, la lingua poetica, quanto più rischia di situarsi nella zona del “già detto”, del “già stato scritto”, di quello che potrebbe definirsi un sapere allegorico (in cui la sostituzione del significato avviene immediatamente distruggendo il corpo del significante) , tanto più diventa in grado di reinventarsi, di essere originale proprio perché capace di riattivare quel tanto di simbolico che la fonda, avverandola all’origine, e di salvare dal naufragio della dimenticanza la tradizione che l’ha resa possibile. Condensando con parole tratte da un dramma tardo di Luzi “la scrittura è scritta ma / la rappresentazione è necessaria”.
Andiamo con calma. La via crucis è un’agonia, il dolore è il primo protagonista. Come fare, però, a renderlo vero, a renderlo personale, sottraendolo al linguaggio dei più, alla tradizione? Pasi riflette su questo aspetto: “Nessuno può comprendere il dolore / di un altro, perché è individuale, / perché è l’essenza della solitudine, / perché non parla mentre lo giriamo, / leggero come un fascio d’erba” (p. 19). È l’agonia del nome proprio che, in quanto proprio, non può essere comunicato nella sua interezza e vividezza senza essere ingabbiato in una rappresentazione che lo depotenzi. Il nome, il dolore, la croce: tutti incomunicabili. Ci si rifà, dunque, a chi l’ha detto prima di noi, alla tradizione, alla biblioteca, si riusano i frammenti del Testo, del Libro. Sia Luzi che Pasi premettono alle loro poesie brani dei Vangeli o dei Salmi (Luzi) o le denominazioni delle quattordici stazioni della via crucis in Exercitium Viae Crucis de Sancto Alphonso Maria de Ligorio (Pasi). Ciò che però non fa ricadere nell’esercizio stucchevole o in una sorta di ekphrasis al letterario questi due testi è che i brani di apertura non vengano descritti, ma agiti: in Luzi è Cristo stesso che parla in prima persona, uscendo dalla terza persona del testo sacro e incarnandosi nella prima persona che dice – dolorosamente – io (“Conoscerò la morte. La conoscerò umanamente” p.35); in Pasi – e in questo si rivela la grandezza della migrazione dei simboli – l’attore della via crucis è il padre dell’autore. Alcuni esempi; la terza stazione della via della croce si apre con la corrispettiva frase latina “…procumbit primum sub onere crucis” ma, a cadere, è il padre colto da un malore che, a terra, si sforza di prendere il telefono allungandosi verso una mensola “come quando / portiere della squadra giovanile, / si allungava per prendere il pallone” (p. 17).
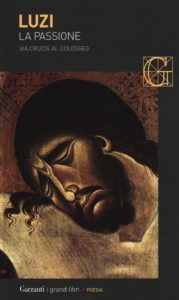 O ancora, alla stazione undicesima, quella della crocifissione vera e propria, mentre il motto recita “…clavis affigitur cruci”, si presenta il padre attaccato alle macchine mediche, un Ecce homo in chiave moderna. “Così questo è mio padre, appeso ai fili / delle apparecchiature che mantengono / le funzioni vitali” (p. 25). Il dolore personale, il nome proprio, indicibile, è detto in maniera simbolica, accennando al simbolo che lo anticipa. Ci si affida ad una verità che precede, che è stata già scritta; tuttavia non la si prende nella sua accezione positiva di ready made, ma la si fa avverare. Il simbolo, più che un qualcosa che sta per qualcos’altro, diviene qui il senso originario dell’esperienza singola; il particolare, per essere detto, si affida al generale, il generale si avvera nel particolare. L’agonia della non appartenenza al campo del dicibile è risolta, da Luzi e Pasi, mediante le potenzialità espressive del simbolo: Luzi fa parlare il simbolo, Pasi trasforma in simbolo il padre.
O ancora, alla stazione undicesima, quella della crocifissione vera e propria, mentre il motto recita “…clavis affigitur cruci”, si presenta il padre attaccato alle macchine mediche, un Ecce homo in chiave moderna. “Così questo è mio padre, appeso ai fili / delle apparecchiature che mantengono / le funzioni vitali” (p. 25). Il dolore personale, il nome proprio, indicibile, è detto in maniera simbolica, accennando al simbolo che lo anticipa. Ci si affida ad una verità che precede, che è stata già scritta; tuttavia non la si prende nella sua accezione positiva di ready made, ma la si fa avverare. Il simbolo, più che un qualcosa che sta per qualcos’altro, diviene qui il senso originario dell’esperienza singola; il particolare, per essere detto, si affida al generale, il generale si avvera nel particolare. L’agonia della non appartenenza al campo del dicibile è risolta, da Luzi e Pasi, mediante le potenzialità espressive del simbolo: Luzi fa parlare il simbolo, Pasi trasforma in simbolo il padre.
Cristo e la Croce si liberano, così, dal destino di figure statiche, valide solo nel tornio di testi e momenti destinati alla loro interpretazione teologica; si aprono, invece, ad una pratica di vita che li avvera nel momento del loro riconoscimento nelle situazioni umane. Non rimangono confinate alla croce del loro nome ma prendono il nome di tutti coloro che li avverano; non a caso Pasi, nel riportare le indicazioni latine in esergo alle sue poesie, sostituisce il nome di Cristo con tre puntini di sospensione…
Il simbolo, così come la poesia, non è qualcosa di già dato, di immobile; è semmai il luogo che attende che qualcuno lo avveri, che lo nomini con un nome che, se all’apparenza sembra straniero o inattuale, è tanto straniero e inattuale quanto il nome proprio.

