Ogni opera d’arte è tale se il suo sviluppo risponde a necessità.
Fabio Tombari
Alta la voce e poca
e vera.
Filippo Davoli
(Questo trepido vivere nei morti)
Ferruccio Benzoni
 Ci sono parole ed esperienze di poesia, in tutte le epoche, ma in particolare in questa fase postmoderna di cui non si intravedono soluzioni di continuità; parole che sembrano aumentare il proprio peso specifico, accentuare la propria verticalità man mano che attorno ad esse si va intensificando il movimento, la comunicazione, che per sua natura è orizzontale. Il compianto maestro Franco Loi ha scritto che la parola poetica non è una parola comune; non è la parola della comunicazione ordinaria. E non perché la parola della poesia debba essere ricercata, sofisticata, erudita, ma perché diversa è la sua funzione: la parola poetica deve mettere in comunicazione con le proprie emozioni, con l’interiorità. Quindi deve sì generare un movimento, che però è interno (“emozione” viene dal latino “motus”, proprio come “Amor che ditta dentro” e “amor che move il sole e l’altre stelle” dell’ultimo verso della Divina Commedia), non è quello esterno della comunicazione superficiale (“C’è nascosto qualcosa in me che mi tocca…c’è qualcosa che mi tocca nella vita/e fa memoria ai richiami del vento”, in una splendida poesia di Loi).
Ci sono parole ed esperienze di poesia, in tutte le epoche, ma in particolare in questa fase postmoderna di cui non si intravedono soluzioni di continuità; parole che sembrano aumentare il proprio peso specifico, accentuare la propria verticalità man mano che attorno ad esse si va intensificando il movimento, la comunicazione, che per sua natura è orizzontale. Il compianto maestro Franco Loi ha scritto che la parola poetica non è una parola comune; non è la parola della comunicazione ordinaria. E non perché la parola della poesia debba essere ricercata, sofisticata, erudita, ma perché diversa è la sua funzione: la parola poetica deve mettere in comunicazione con le proprie emozioni, con l’interiorità. Quindi deve sì generare un movimento, che però è interno (“emozione” viene dal latino “motus”, proprio come “Amor che ditta dentro” e “amor che move il sole e l’altre stelle” dell’ultimo verso della Divina Commedia), non è quello esterno della comunicazione superficiale (“C’è nascosto qualcosa in me che mi tocca…c’è qualcosa che mi tocca nella vita/e fa memoria ai richiami del vento”, in una splendida poesia di Loi).
Quando la parola è necessaria acquista una forza che resiste all’usura del tempo. La parola sembra incisa su una pietra ed assume, nel suo resistere, una valenza morale e civile.
E’ il caso della parola di Francesco Scarabicchi, altro Maestro venuto tristemente a mancare, e a cui voglio rendere onore dopo i miei interventi su Pasolini e due “figli” di Sereni come Remo Pagnanelli (il suo La ripetizione dell’esistere, proprio su Sereni) e Ferruccio Benzoni. Soprattutto è significativo che io stessi approfondendo Scarabicchi dopo uno scritto su Benzoni, considerando lo stretto legame di amicizia tra i due poeti: il poeta anconetano ha anche dedicato a Benzoni alcune liriche. Ma c’è un elemento fondamentale che li accomuna profondamente. Se per Benzoni l’atto di nascita della sua poesia era stato fatto risalire al 25 luglio 1967, giorno della scomparsa della madre, e in fondo ogni suo verso era destinato a tornare a quella data fatidica; anche la poesia di Scarabicchi torna insistentemente su un lutto originario, senza riferimenti coloristici, in questo caso (si ricordi, per Benzoni, del tailleur azzurro che la madre indossava nell’ultima immagine impressa nella memoria del poeta di Cesenatico), se non il reiterarsi del bianco e della ferita, due dei poli entro i quali si muove il suo universo simbolico, a partire dalla perdita del padre. Come non pensare, in questo prevalere del bianco, al Lukacs che coglieva nel bianco una reminiscenza materna, a proposito dei romanzi di Pratolini. Certo potremmo estendere tale appunto a una generale condizione di orfanità, al vuoto che ne deriva e dunque anche alla pagina bianca o più in generale al prevalere del bianco nella pagina di Scarabicchi la cui scrittura si è andata sempre più rastremando dimentica degli esordi sperimentali de La mente devastata. Ed è sul finire di quell’esperienza sperimentale che si compie in Scarabicchi qualcosa di decisivo, l’approdo allo scandaglio psicanalitico, una svolta che lo differenzia totalmente da Benzoni, piuttosto diffidente in proposito:”Paura che l’analisi disseccasse la mia capacità di scrivere poesie. Sentivo che la mia poesia nasceva da un gomitolino molto aggrovigliato e intorcinato. Avevo paura che un giorno tutto mi diventasse chiaro e, con questa chiarezza, fuggisse appunto da me la poesia” (da un’intervista). La scelta di Scarabicchi sarà invece quella di fare i conti con la propria condizione di orfanità sublimando tuttavia questo scandaglio nella metafora del gelo e della neve, dell’attraversamento di un inverno dell’assenza, un inverno della sua storia personale e della Storia di tutti. Naturale poi pensare alla metafora della neve e dell’inverno in Paul Celan, riferimento importante nonostante a livello stilistico l’influenza si riveli piuttosto indiretta.

La forza della scrittura di Scarabicchi risiede tutta nella potenza etico-estetica della parola, nella sua essenzialità, nudità, frutto di un’estrema urgenza, di una necessità interiore cui presiede un accurato labor limae. Se la scelta di Benzoni era stata anche nella direzione dell’ornatus, della bellezza ed eleganza del verso, il poeta anconetano sembra al contrario aver fatto proprio il precetto seguìto da Cristina Campo, dal Vangelo di Matteo:”di ogni parola vana che gli uomini diranno, dovranno rendere conto”.
Nella sua radicale verticalità, la parola poetica spezza la comunicazione orizzontale di oggi, come la comunicazione della tv dove “non si salva una sola parola”, diceva Pasolini. Questa, di proteggere l’integrità della parola, mi sembra invece una delle principali responsabilità della parola poetica, responsabilità di cui la parola di Scarabicchi si sente investita in prima persona, a partire dalla consapevolezza di una verticalità, appunto, attraverso la quale, come ricordava l’anconetano, con la massima economia di mezzi, un foglio e una penna, è possibile esprimersi in un linguaggio lirico, narrativo, musicale o figurativo. Di fronte alla pagina di Scarabicchi colpisce la straordinaria concentrazione di senso in poche sillabe che è prerogativa di Ungaretti, Celan, l’ultimo Caproni; davvero evidente l’economicità dei mezzi espressivi in alcuni versi come questi, da Il viale d’inverno (1989):
Tutto sommato,
quello che conta è poco,
il resto va,
polvere d’ogni vivo,
quel di più che non giunge
a perfezione alcuna.
E senza che il discorso, tuttavia, si perda in una eccessiva rarefazione astratta e simbolica, poiché, ci teneva a precisare lo stesso autore, “nessuna arte è astratta, ma è sempre corpo, respiro, sangue” (da un’intervista).
Lo scandaglio psicanalitico ha portato alla luce già ne La porta murata (1982), poesie indimenticabili; in una conversazione Scarabicchi citava Giorgio Caproni che considerava il poeta come un minatore, che dalla superficie, dall’autobiografia, scava finché trova un fondo nel proprio io che è comune a tutti gli uomini; o ancora un subacqueo che scende nelle viscere dell’io e, miracolosamente, torna in superficie con poche, lucenti pepite:“Il poeta è un minatore, è poeta colui che riesce a calarsi a fondo in quelle che il grande Machado definiva las secretas galerias del alma (le segrete gallerie dell’anima). E lì attingere quei nodi di luce che sotto gli strati superficiali, diversissimi tra individuo e individuo, sono comuni a tutti, anche se pochi ne hanno coscienza.
 L’esercizio della poesia rimane puro narcisismo finché il poeta si ferma ai singoli fatti esterni della propria persona o biografia. Ma ogni narcisismo cessa non appena il poeta riesce a chiudersi e inabissarsi talmente in se stesso da scoprirvi, ripeto, e portare al giorno quei nodi di luce che non sono soltanto dell’io ma di tutta la tribù” (Sulla poesia).
L’esercizio della poesia rimane puro narcisismo finché il poeta si ferma ai singoli fatti esterni della propria persona o biografia. Ma ogni narcisismo cessa non appena il poeta riesce a chiudersi e inabissarsi talmente in se stesso da scoprirvi, ripeto, e portare al giorno quei nodi di luce che non sono soltanto dell’io ma di tutta la tribù” (Sulla poesia).
L’immersione di Scarabicchi nella propria biografia, ne La porta murata, avviene nella direzione di un tentativo di recuperare quanto perso attraverso la memoria, alcuni ricordi del padre immersi in una dimensione vicina a quella del sogno, ma assolutamente spogli di qualsiasi tipo di décor surrealista:
Ci si rammenta a volte
d’un nome,
un volto
còlto da la memoria
con tac d’interruttore,
lui che ragazzo
gioca agli indiani e solo
per errore
con il gomito infrange
la cristalliera ad angolo:
in ginocchio raccoglie
i frantumi in vetro
e chi lo scruta avverte
l’appena bisbigliato
come tornare indietro?
L’evento irreparabile della perdita del padre, come l’infrangersi maldestro di una cristalliera, non viene rivissuto in termini elegiaci; l’espressione è quanto più asciutta e incisa possibile. Nella sua perfetta introduzione, Franco Scataglini riporta un altro testo fondamentale, che traduce la risposta a una domanda del figlio al padre, “Cos’è la morte?”; “E’ andare per treno in un posto dove non ci sono più stazioni” in un’altra scena domestica che si carica ancora una volta di rimpianto:
Lavandosi s’accorse che al catino
mancava de lo smalto nel fondo:
vide la piccola macchia
asciugandosi verso la finestra;
si voltò impaurito
come chi,
con la valigia in mano,
vien fatto scendere a un binario morto.
“Non ci sono per sempre più stazioni”
disse come uscito da un sogno.
La mancanza, dal fondo, come dirla?
Ci sovviene certamente l’allegoria del treno in Caproni, nel Congedo del viaggiatore cerimonioso e non solo, ma priva in Scarabicchi degli scenari purgatoriali del grande Maestro: nel poeta anconetano il viaggio si interrompe troppo presto (allusione alla perdita precoce del padre, a una ferita originaria); se in Caproni l’ultima stazione diveniva metafora del destino che attende ciascuno, il viaggiatore di Scarabicchi, con la valigia in mano, viene fatto scendere a un binario morto.
Nell’interrogazione finale il poeta dichiara se non l’impotenza, ma almeno l’insufficienza della parola a dire la mancanza. Per farsi tramite, medium tra i vivi e i trapassati, la poesia dovrà quindi ridursi a una semantica “scabra ed essenziale”, per dirla in termini montaliani; il paradosso fecondo della lirica di Scarabicchi risiede, in questo caso, in quello che Enrico Testa ha definito il suo “monachesimo lessicale”. E del resto è possibile estendere il concetto di monachesimo e di strenua fedeltà, anche etica, all’esercizio paziente dell’anconetano; esercizio che in quanto autentico, radicale, esistenziale, non è mai riconducibile a un livello meramente letterario e stilistico.
Ne La porta murata, sua prima vera opera, il poeta anconetano esordisce con un’altra interrogazione, a dimostrazione, a mio parere, dell’ineluttabile carattere leopardiano di questa poesia; eredità quasi irrinunciabile nei marchigiani, come già aveva notato Carlo Antognini, quando notava una tendenza più incline alla malinconia che alla tristezza, all’interrogazione più che all’angoscia. Dal fondo di angoscia, nella lirica di apertura, si leva l’energia dell’interrogazione:
Non è stato un ritorno il riapprodare
a l’isola nascosta de la casa.
Credo fosse il dicembre d’un natale felice,
la pioggia che batteva il lungomare,
le stanze vuote come gusci d’uovo.
In piedi nel vano de la porta
(il segno dei quadri a le pareti),
come se fossi stata muta al fianco
ti ho chiesto:”I vivi di qui
adesso dove sono?”
L’interlocutore è muto o non può rispondere, ma il poeta deve comunque porre la domanda, esattamente come il Leopardi del “Che fai tu luna in ciel?” di fronte alla “silenziosa luna” ne Il canto notturno d’un pastore errante dell’Asia. Il segno dei quadri alle pareti, come quello della porta murata che dà il titolo alla raccolta, è naturalmente il segno dell’esistenza dei sommersi; segno in altre liriche spesso coperto, come in Celan, dalla neve; così come “le povere cose” dei propri cari:
L’inverno più crudo
de la nostra storia
quando la neve rovinò anche il tetto;
l’andare e venire dal solaio
per l’acqua che bagnava
i tuoi mobili smessi,
i tuoi cappelli
d’amata gioventù
chiusa in scatole e ceste.
In cucina piangevi
come per una morte,
con voce di bambina
a nessuno dicevi:
“Le mie povere cose di una vita,
è bastata la neve a cancellarle.”
O ancora, in un valico di frontiera, un doganiere d’Austria giunge “sotto la tanta neve/che sciogliendo sbiadiva/non rammento/se il tuo nome/o il mio, sul documento.” Proprio Celan era ricorso all’allegoria della neve (si veda, ad esempio, la famosa Letto di neve in Grata di parole), presenza ossessiva della sua produzione, a simboleggiare il rischio della rimozione dei sommersi (le vittime dell’Olocausto senza un nome), esattamente come nella sua vicenda personale non aveva la certezza di dove fossero le spoglie dei genitori morti, né la data esatta della loro dipartita. Mi sembra che la poesia di Scarabicchi viva della stessa tensione spasmodica a voler conservare, fissare il nome e la data (Il nome e l’anno è il titolo di una delle sue liriche più belle), sottrarli all’oblìo e alla rovina rapinosa del tempo:
Come cristalli de la neve
gli affetti quando […]
con occhi da sgomento
solo a me nota la data,
su la lapide
sbagliata la nascita;
in un filo di voce ho confessato
all’uomo col basco l’errore
verso l’uscita – in una mano
i pochi anni senza custode.
Come aveva notato Roberto Galaverni per Benzoni, anche Scarabicchi “sente per sottrazione e scrive per restituzione”. Con la differenza che l’elegia benzoniana necessitava di un’eleganza formale e di un culto della bellezza cui l’anconetano rinuncia per scavare a fondo nel dolore della verità, rastremando quanto più possibile la forma e tentando di sottrarre un nome, una data o un oggetto al non-senso del mondo. La luce del poeta-minatore è la luce fioca delle lanterne, delle lampade ad olio che si consumano lentamente. Così scrive Scarabicchi ne Il prato bianco (1997), con una poesia che ha in esergo una citazione dal Purgatorio dantesco (“L’alba vinceva l’ora mattutina…”), libro quantomai “caproniano”:
Porto in salvo dal freddo le parole,
curo l’ombra dell’erba, la coltivo
alla luce notturna delle aiuole,
custodisco la casa dove vivo,
dico piano il tuo nome, lo conservo
per l’inverno che viene, come un lume.

A una simile condensazione di significato in pochi versi Scarabicchi giunge dopo un lungo e paziente percorso, snodatosi
lungo quella prima svolta, frutto di una feconda analisi personale in stretta relazione con l’irriducibile esistenzialismo di questa scrittura, ne La porta murata. A questa prima apertura delle “riserve umane di dolore” (Mario Luzi), ha fatto seguito un altro passaggio evidente, quello de Il viale d’inverno (1989), prova già matura della sua musa domestica, familiare, minore, come lo stesso autore certifica, ma non per questo meno resistente. Non a caso Massimo Raffaeli, nello scritto che chiude il libro, ha parlato di “consapevole e virile accettazione dell’esistere” in un “segno” che “resarcisce la perdita nel momento in cui sembra decretarla”: una poesia dunque che si aggrappa ai residui incancellabili che l’esistenza lascia (di nuovo una data, un nome). E si noti come i testi che aprono e chiudono la raccolta siano in corsivo, parole sperse che vanno e vengono dalla polvere:
Il nome (il nome)
a nessuno mai detto
e che pronunci
in un filo di voce
in gran segreto.
Ma le “desinenze/che la lingua declina” consentono il colloquio silenzioso, segreto con i propri cari: il padre, ricordato per istantanee (“tu sulla porta/con una mano in tasca/e un fischio di romanza/sulla bocca); la madre, la cui perdita lascia al poeta la “certezza del gelo”, un “mai più” che si salda a un pervasivo “per sempre” (presente in tutti i Tre movimenti), a conferma della dimensione tragica, ma al contempo agonistica di Scarabicchi, della lotta sottaciuta contro il principale nemico, il tempo. Anche in questo senso va interpretato l’altro ossimoro presente, quello del “freddo fuoco”. In una dialettica di resistenza e resa, la parola sanziona, sancisce la perdita (“Arde un gelo di gemme”) di un io decentrato, ma non inerme. Per questo non sorprende che il poeta anconetano chiuda la sua serie circolare di epigrafi con una sorta di dichiarazione di poetica, affermando quanto la parola debba farsi disponibile all’ascolto profondo delle “voci delle cose”:
Come salva dal sogno
la stella dell’aurora,
come dal niente lascia
che silenziose salgano,
ai rami del risveglio,
le voci delle cose.
Se il mood resta quello dell’accompagnamento funebre lungo il viale d’inverno che dà anche il titolo alla sezione dedicata alla madre; e se le immagini più emblematiche e vivide provengono dai segni di un’umanità prossima alla fine, alla cancellazione:
Freddi fianchi del giorno
i muri a cui si approssima
l’inverno con la pioggia
che cade sopra gli uomini
e li cancella piano
Scarabicchi non rinuncia alla dolcezza familiare nel ricordo dei propri cari, la cui perdita resta l’unico marchio impresso in rilievo sulla propria esistenza; al calore domestico del ricordo si affiancano i risvolti penniani di alcuni degli epigrammi o mottetti del volume, come Aprile:
Più che nel sogno, in me
sparisca sempre
quest’immobile inverno
nei rigori dell’acqua
e torni la gentile –
di là dai vetri –
chioma della luce.
La vocazione all’essenzialità della forma, spia di una condizione di perenne orfanità, raggiunge i suoi vertici maturi ne Il prato bianco. Il libro, uscito come Il viale d’inverno per le piccole, raffinate edizioni de L’Obliquo di Brescia, nel 1997, è stato ristampato solo quattro anni fa, nel 2017 per la Einaudi. Scarabicchi non ha fatto mistero dell’incomprensione da parte della critica già ne L’esperienza della neve (2003), quando scrive:
Ma voi dov’eravate quando c’ero,
quando solo vi aspettavo,
ospite di un dolore che si perde
oltre la luna che più in là è settembre?
Certo in Scarabicchi il permanere assillante della metafora dell’inverno scaturisce non solo dal percepire la propria esistenza come inverno, ma dalla naturale disposizione lirica ad estendere la propria condizione di orfanità, all’orfanità di una generazione (lo smarrimento simboleggiato dall’assenza di una figura come Pasolini); la consapevolezza, come già in tanti titoli di fine secolo (naturalmente il Viaggio d’inverno di Bertolucci, ma anche i più recenti Sguardo dalla finestra d’inverno di Benzoni, Residenze invernali della Anedda, Atelier d’inverno di Pagnanelli) dell’attraversamento, da parte della poesia, di un inverno-inferno della Storia, come notò in modo limpido lo stesso Pagnanelli critico in uno scritto dal titolo Paesaggio invernale (o quasi).
Diversi inoltre sono i testi in cui il poeta anconetano sembra dichiarare apertamente, senza alcuno spiraglio consolatorio, l’impossibilità di superare il lutto:
Ecco cos’è, ogni volta,
la vacanza
nel lontano da sé,
la strada bianca
su cui l’ombra di un’ombra
un’ombra affianca
al nulla muto
che non ha speranza,
quel povero deserto
d’ore insonni
in cui tutto, per sempre,
è eterno e niente.
(da Il prato bianco)
Leopardi, certo, ancor più forse l’ultimo Caproni, molto prossimo anche su un piano stilistico e semantico, pur essendo il Nostro lontano dal pessimismo gnoseologico di quest’ultimo. Non mi sembra infatti che la poesia dell’anconetano esuli mai dal circolo degli affetti e dei Maestri (Il prato bianco è dedicato a Scataglini), anche quando, a partire da L’esperienza della neve, vorrà riproporre una sua versione del modello del Canzoniere di Saba, in forma di liriche dedicate alla moglie o di missive per i figli. Credo che la forza della poesia di Scarabicchi sia proprio in questo saldare necessario del circolo degli affetti con i Maestri d’elezione, quelli della tradizione italiana, nessuno escluso:
Ci vorrà
Ci vorrà
tutto il tempo necessario
prima che possa anch’io
fare a meno di me
senza voltarmi,
andando,
per lasciare.
(da Il prato bianco)
Si pensi, in quest’ultimo caso, al Montale de “gli uomini che non si voltano” o all’Ungaretti del “come portati via si rimane”; ma, onde evitare di scadere nella ricerca di citazioni da repertorio, che non si addicono alle consonanze e corrispondenze profonde della poesia di Scarabicchi con i Maestri del Grande Stile, non va dimenticato il senso del legame con i Maestri stessi, che permette di comprendere il reale significato di versi lapidari come:
Pensami in questa lingua che resiste
a dire d’ogni vivo quel che manca.
(da L’ora felice, 2010)
Il senso è l’attraversamento dell’inverno della Storia e del postmoderno con l’energia virile e leopardiana di una poesia che non si vieta di cantare (quanto del melodismo di Gatto c’è nello Scarabicchi degli anni Duemila), ma ritrova spinta non per dilatazione delle sfere semantiche. Senza nulla perdere in severità e misura, la rivivificazione di questa poesia avviene intensificando e risignificando parole consuete, proprio quelle “trite parole che non uno/osava” di sabiana memoria, nella lunghezza più classica della tradizione italiana, l’endecasillabo:
Il nome e l’anno
Voglio cantarti una canzone antica,
battere sui tre quarti il nome e l’anno,
dirti che t’amo più della mia vita,
rammentare di te il dono e il danno,
stella che m’ardi il cielo della notte,
quanto di te ho parlato all’altra gente,
quante volte ho bussato alle tue porte,
quante strade ho percorso inutilmente.
Ora che sono qui dove mi vedi,
tu non scacciarmi come fossi niente,
baciami sulla bocca, se ci credi,
portami dove il male non si sente.
(da L’esperienza della neve)
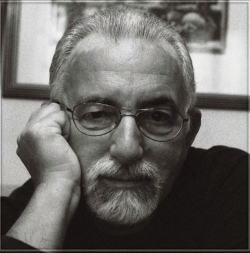 Da molto tempo mi ripromettevo di scrivere della poesia di Scarabicchi, poesia che conosco ormai da vent’anni, proprio grazie agli incontri di Ciminiera cartacea, nei primi Duemila. Straordinaria, tra l’altro, per quel poco che ho potuto conoscere l’uomo, la corrispondenza dei versi con l’umiltà, il pudore, il decoro che emanavano dalla sua figura. Avrei voluto rendergli onore, se ne sono stato un minimo capace, prima. Per il valore così solenne della sua fedeltà alla poesia e alla vita, credo che vada reso umilmente merito a Francesco Scarabicchi, alla sua tensione ferma, ma inesausta, nel colmare di senso quel vuoto che abita al fondo della nostra finitudine.
Da molto tempo mi ripromettevo di scrivere della poesia di Scarabicchi, poesia che conosco ormai da vent’anni, proprio grazie agli incontri di Ciminiera cartacea, nei primi Duemila. Straordinaria, tra l’altro, per quel poco che ho potuto conoscere l’uomo, la corrispondenza dei versi con l’umiltà, il pudore, il decoro che emanavano dalla sua figura. Avrei voluto rendergli onore, se ne sono stato un minimo capace, prima. Per il valore così solenne della sua fedeltà alla poesia e alla vita, credo che vada reso umilmente merito a Francesco Scarabicchi, alla sua tensione ferma, ma inesausta, nel colmare di senso quel vuoto che abita al fondo della nostra finitudine.
